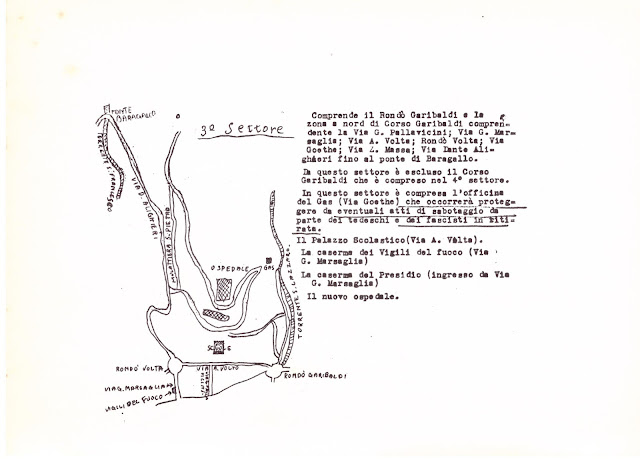|
Briga Alta (CN) - Fonte: Mapio.net
|
Abbiamo visto come, preceduti da tre giorni di cannoneggiamenti, reparti tedeschi provenienti da Isolabona, Saorge e Briga, l'8 ottobre 1944 avessero costretto i reparti garibalbini nella
zona di Pigna a ripiegare sotto la minaccia di accerchiamento.
Riassumendo: il rastrellamento continua incalzante. Il distaccamento di «Barba» arretra dal monte Vetta. Una pattuglia del 5° distaccamento, armata di due fucili mitragliatori, è inviata in direzione di Castelvittorio per accertare lo stato delle cose, i movimenti nemici e appoggiare eventuali formazioni che già combattono.
La zona che si estende dal confine francese a Pigna e che scende a Castelvittorio-Buggio-Carmo Langan, alle ore 22 non è più sotto il controllo garibaldino; della situazione viene informato con un messaggio anche il 3° battaglione della IV brigata e l'8° distaccamento di «Gori» della V brigata, ritornato nella zona di Beusi a monte di Taggia.
Dopo monte Vetta è perduto il passo Muratone; il distaccamento comando della V brigata è obbligato a indietreggiare da Carmo Langan e a ritirarsi su Triora. Il Comando brigata si prefigge, nell'eventualità di una ritirata, di seguire la direttrice Triora-Piaggia per raggiungere il Comando divisione.
Il distaccamento di «Moscone» che si trovava a Cima Marta per proteggere Pigna dal lato di Briga e che, esaurito il suo compito, attendeva ordini precisi, alle 11 del giorno 9 è messo in allarme dalle vedette; una colonna tedesca sale da Briga, il distaccamento si mette in postazione e l'attacca con raffiche di mitraglia per rallentare la marcia e permettere alla colonna dei muli diretta a Bregalla di guadagnare terreno e mettersi al riparo. Gli acquazzoni si susseguono incessanti per tutta la giornata e i garibaldini sono bagnati fino alle ossa; camminano stanchi e taciturni
[...] la I brigata pone vigilanza alla strada che da Collardente porta alla galleria del Garezzo ove sono in perlustrazione pattuglie avanzate tedesche.
Il distaccamento di Gino
Napolitano (Gino) che, dopo essersi trovato in grave difficoltà, da sud-ovest del monte Ceppo si era già portato a Carmo-Langan e poi a Buggio, riesce a riordinarsi a Triora insieme agli altri reparti.
Nei giorni 10 e 11 la calma si ristabilisce. Il nemico sembra avere subito una battuta d'arresto; sembra stia ordinando le fila, preparando nuovi piani d'attacco.
Le perdite sono gravi, molti gli sbandati e le armi perdute.
Durante questa tregua il distaccamento di «Gino» ritorna a Langan con lo scopo di proteggere il ripiegamento della formazione partigiana da un eventuale pericolo di sorpresa.
[...] Il lavoro dei commissari, provvisoriamente interrotto viene riattivato a Triora; si curano i migliori elementi per poi darli affidati ai tre battaglioni della brigata in via di ricostruzione. In questo precario periodo di vita della V brigata i garibaldini hanno dimostrato grande compattezza e massimo coordinamento coi Comandi; ciò verrà confermato nei giorni successivi con l'ulteriore spostamento a Piaggia [Frazione di Briga Alta (CN)], poi a Carnino e indi a Fontane in Piemonte.
Sul ripiegamento ordinato della V brigata, il garibaldino Giulio Manasero (Lulù) racconta: « ... Con l'attacco tedesco a Pigna, non potendo resistere al nemico, i distaccamenti della V brigata riuscirono a ripiegare con ordine, ma questo avvenne anche grazie all'impianto telefonico che ero riuscito a costruire con tenacia e pazienza. Messomi al lavoro dopo l'occupazione di Pigna da parte dei partigiani, avvenuta negli ultimi giorni di agosto, mi misi a collegare con linee telefoniche tutti i distaccamenti della V brigata dislocati su un largo territorio che si prolungava fino a Langan. Con la mia esperienza, costruii un centralino, smontando e selezionando i pezzi di vari apparecchi da campo già in dotazione all'esercito, abbandonati da settembre 1943 nelle varie casematte situate in montagna, come quelle di Margheria dei Boschi, di Muratone, di Lega. Il centralino venne innestato alla ex linea pubblica già dalla "Società dei telefoni e telegrafi", così Langan, Pigna, Marta, Baiardo, Molini di Triora e Badalucco vennero collegati tramite questo ingegnoso lavoro che svolse per un mese un servizio efficiente e, come ho detto all'inizio, fu un prezioso elemento, anche per la salvezza di tutti i distaccamenti nel corso del rastrellamento. Inviati gli ultimi messaggi, con i Tedeschi nelle vicinanze, mi incaricai di distruggere tutti gli impianti...».
Intanto il distaccamento di «Franco» raggiunge Piaggia assieme ad una quindicina di garibaldini di «Leo».
Da Ventimiglia giunge notizia che i tedeschi stanno risalendo la valle del Roja in forze, lasciando sulla costa solo elementi della Marina, mentre a Oneglia pattuglie formate da nazisti e brigate nere partono per perlustrare le strade che danno accesso alle vallate.
La situazione diviene nuovamente critica.
I Tedeschi, distruggendo e incendiando case e fienili per la campagna, compaiono nei dintorni di Triora e la banda locale di Molini si sbanda.
Anche la IV brigata si prepara al peggio: il 7° distaccamento di «Veloce» si tiene pronto a partire per spostarsi sotto monte Ceppo sperando di venirsi a trovare alle spalle dello schieramento nemico, qualora questi operasse verso sud in valle Argentina; nella notte sotto il monte giungono garibaldini sbandati del distaccamento di «Gino» attaccato in mattinata a Langan. Molini è investita da colonne di nazifascisti che riprendono l'offensiva il mattino del 13.
Le prime raffiche prolungate si odono di fronte all'accampamento del distaccamento «Moscone»; colonne di fumo s'innalzano dai tetti delle case di campagna in località Goletta, il nemico dà fuoco a tutto quello che scorge, compresa la casa ove era stato il Comando della V brigata.
Il distaccamento riesce a prendere posizione sul monte Castagna e a rimanervi per quattro ore. Al tramonto, ricevuto l'ordine da «Vittò» di spostarsi, dopo una marcia notturna sotto lo scrosciare incessante della pioggia e per sentieri invisibili ed infangati, raggiunge il paese di Piaggia sul fare dell'alba. I Tedeschi avevano annunciato il loro arrivo a Triora con una breve sparatoria su Langan, dopo aver attraversato il bosco di Tenarda; come abbiamo accennato, incendiati i casoni della Goletta, scendono per i castagneti di Mauta e giunti in località La Besta non proseguono sulla via maestra ma deviano per una scorciatoia che porta alla Noce, indizio evidente che qualche conoscitore dei luoghi li stava guidando.
Giunti nel luogo detto Casin sparano al campanile del capoluogo, come avviso del loro arrivo.
Ondate di soldati tedeschi si susseguono per tutta la giornata. Si fermano nel paese occupando le case private Tamagni, Capponi, Bonfanti, Ausiello, Costa, Moraldo, ecc. L'artiglieria sosta sotto i portici dell'asilo e dell'ospedale; ivi sostano pure le cucine della truppa, mentre la sanità viene si ternata in casa di Lina Novaro (La Baracca) ed i cavalli nella scuderia del «Casermone».
Intanto tutta la V brigata è in ripiegamento verso Piaggia. Avviene in modo ordinato e con calma. Al tramonto del 13 tutti i distaccamenti sono nella zona in attesa di una sistemazione provvisoria. In due giorni la formazione viene riorganizzata con gli effettivi rimasti in efficienza comprendente 350 garibaldini. Mancano ancora i distaccamenti di «Gino» che, rimasto tagliato fuori, riuscirà in seguito a raggiungere Piaggia attraverso il passo della Mezzaluna e la galleria del Garezzo, scansando le colonne nemiche, e l'8° distaccamento di «Gori», in posizione avanzata a Beusi, a monte di Taggia, ove rimarrà per tutto il mese appoggiato a levante dal 3° battaglione di «Artù» della IV brigata
«...il Comando partigiano è sempre a Piaggia; all'intorno sui passi, nei casoni, sulle cime, ancora distaccamenti e pattuglie. Pioggia, fango, umido, nevischio; lento stillicidio dei giorni, la neve è appena sulle cime, l'inverno avanza minaccioso. Il giorno 13 mattino s'ode distinto il rombo del cannone. La V brigata è ancora attaccata; riuscirà ancora a tenere? La domanda ansiosa fa tremare il cuore.
"Osvaldo" [Osvaldo Contestabile] era stato nominato commissario della V e il 5 di ottobre aveva salutato quelli della I brigata prima di lasciarli e rivoltosi al garibaldino Gino Glorio (Magnesia) aveva detto: "Vuoi venire con me? Andiamo verso il fronte, saremo i primi ad essere liberati". "Osvaldo" era partito con la sua pesante coperta sulle spalle... sarebbe stato mai più rivisto?
"Abbiamo ricevuto dal Comando tedesco una specie di ultimatum. Se ci impegnamo a non attaccare ulteriormente i collegamenti tra il fronte e le retrovie, se lasciamo libere le strade, il nemico s'impegna a non molestarci, in caso contrario comincerà il rastrellamento (vedi precedente capitolo: "La battaglia di Pigna")": così il commissario "Osvaldo" scriveva al Comando della "Cascione". La risposta dei garibaldini è netta e decisa: se i Tedeschi sono disposti a lasciare la Liguria, le azioni di disturbo cesseranno, finchè rimarranno sulla nostra terra sarà nostro diritto e dovere attaccarli ad oltranza. Le formazioni partigiane sono cosapevoli di essere più deboli, che il nemico non minaccia invano, può sgominarle, forse per sempre, ma nulla le piegherà a trattare; la sfida sanguinosa è lanciata, se ne sopporteranno le estreme conseguenze.
Il nemico attacca, ritira le truppe dal fronte e le lancia contro di noi, ritira gli alpini scelti, le artiglierie da montagna e rovescia una valanga di fuoco sulle posizioni della V. I nostri ripiegano, attendono che il bombardamento si plachi, più veloci tornano in linea e attendono a piè fermo il nemico che sale all'attacco. Più volte il tedesco è respinto; poi riesce a infiltrarsi, la prima linea cede, Pigna è perduta. La V ripiega su monte Ceppo, Langan, Cima Marta a copertura di Triora.
L'attacco nemico prosegue; ancora artiglierie, bombardamenti, assalti, ancora i nostri senza cannoni e trincee lasciano le posizioni durante il fuoco per tornarvi subito dopo; ancora tre volte il nemico è ributtato con perdite sanguinose; ora, però, il rombo del cannone è troppo vicino e frequente.
A sera giungono i primi sbandati sotto la pioggia che cade insistentemente. Chi ha una coperta, con quella si ripara dall'acqua, alcuni hanno anche lo zaino, altri hanno tutto perduto, scendono dal Frontè, camminano da ore tra la neve ed il fango. Nella notte il Comando divisionale è pieno di garibaldini della V; sono infangati, bagnati, sfiniti, il morale però è alto, forse più alto di quello dei partigiani della I; già, si è sempre sollevati quando si esce da un rastrellamento, si sfugge da un pericolo, si arriva in una zona controllata dai nostri.
"Ciao, 'Magnesia', come vedi sono tornato... però è andata male". Era 'Osvaldo', il commissario della V con la coperta a tracolla. "Petroni", un uomo di "Umberto" racconta le ultime fasi di vita di una banda: il rastrellamento di San Romolo, la scomparsa del capitano "Umberto": "Ora sono con la V, ce ne sono anche altri... No, 'Marcello' non è con noi, è andato in missione verso San Remo ed è scomparso".
Nella stanza c'è un brusio continuo, partigiani arrivano e ripartono, vengono a cercare un compagno, una banda perduta, chiedono notizie, informazioni, si fermano un po' e poi escono a cercare un fienile. Raccontano i particolari della lotta: il nemico molto superiore aveva attaccato di sorpresa approfittando della nebbia.
Cima di Marta era andata perduta e poi, dopo breve e violenta lotta, la disfatta. Certi distaccamenti sono stati tagliati fuori e si ignora la loro sorte, altri hanno perduto i capi, altri si sono sfasciati.
Alcuni, i più, hanno conservato le armi, la compattezza e ripiegano ordinati; hanno ricevuto l'ordine di fermarsi perchè Pigna si va congestionando. Sono indicati loro i luoghi dove accamparsi.
Rapidi e febbrili fervono a Piaggia i preparativi; gli sbandati vengono nutriti, riequipaggiati secondo le possibilità, inquadrati nuovamente; i distaccamenti meno provati sono nuovamente in postazione per rinforzare lo schieramento della I che protegge l'alta val Tanaro dal lato est contro minacce provenienti da Pieve e da Garessio; la V terrà il fronte sud-ovest: Tanarello-Frontè.
Pattuglie partono in tutte le direzioni per segnalare il nemico e prevenire sorprese. Triora, Langan, Molini sono di nuovo occupati dal tedesco che chiedeva con insistenza: "Dov'è Piaggia? Dov'è il Comando?".
La minaccia si aggrava, i documenti vengono nascosti, l'ospedale di Valcona è sciolto; tutti quelli in grado di camminare vengono rimandati in formazione.
Verrà tentata una resistenza ad oltranza. Ogni ora giungono staffette, notizie, comandanti per discutere; si organizza una riserva al centro, si destinano i comandi; il comandante, il commissario e il capo di Stato maggiore della brigata assumeranno la guida dei tre battaglioni, si fanno previsioni sulle direttive di attacco, tutto pare calcolato; c'è però una cosa che si saprà in seguito e che i comandanti sanno: che mancano le munizioni.
Il punto debole della guerra partigiana sono ancora e sempre le munizioni. Per la guerriglia e l'imboscata necessitano pochi colpi: una raffica e tutto è fatto. Per la resistenza, invece no, per tenere una posizione oltre alle armi occorrono i colpi e le armi della I brigata hanno già sparato a Cesio e a Vessalico ... Piaggia è l'ultimo tentativo di apporre al nemico uno schieramento, di tenere una posizione.
I garibaldini non conoscono la reale situazione, il Comando sa e medita. Le possibilità sono varie: sgombrare subito e portarsi in un'altra zona; ma quale? Nessuna presenta garanzie di sicurezza e il nemico avrebbe attaccato ugualmente dirigendo nella nuova direzione le forze ammassate.
In tal caso, la zona di Piaggia, data la scarsità di carrozzabili, sembra la migliore.
Resistere od evacuare durante il rastellamento? L'ultima ipotesi sottrarrebbe le forze partigiane all'attacco nemico, obbligherebbe quest'ultimo a ricominciare da capo tutti i preparativi concedendo così una sosta valutabile a circa un mese.
La difficoltà sta nella scelta della direzione di marcia, nella impossibilità di aver notizie recenti e precise sui movimenti nemici, nella difficoltà di mantenere rapidi collegamenti con i distaccamenti durante la marcia.
Per evitare un sicuro sbandamento che potrebbe, dato l'avvicinarsi dell'inverno e la conseguente demoralizzazione, avere conseguenze più gravi del solito, si decide per la resistenza. Sabato 14 di ottobre: una colonna tedesca di forza imprecisata raggiunge Ormea, è l'inizio; i feriti di Piaggia vengono in fretta evacuati verso Upega, il piano di resistenza contro l'attacco da due direzioni entra in azione, due distaccamenti partono per intercettare il nemico a Ponte di Nava.
L'ansia è nel cuore di tutti.
La giornata di domenica 15, dopo tanta pioggia, è finalmente serena; tutto è tranquillo, silenzioso; si stenta a credere che il rastrellamento sia già iniziato; il cuore, inconsciamente, si apre di speranza ...
Purtroppo la speranza dura poco tempo. Il nemico prosegue il grande rastrellamento iniziato a Pigna il 5 di ottobre. Il giorno 17 a Upega [Frazione di Briga Alta (CN)] sorprende il Comando della II divisione "Felice Cascione".
Cadono valorosi comandanti partigiani. La V brigata "L. Nuvoloni", con la I "S. Belgrano", attraverso il passo del Bocchin d'Aseo (Mongioje) si ritira a Fontane (CN), in Piemonte.
Rientrerà nei primi giorni di novembre in Liguria per riprendere la lotta, che condurrà dura e ininterotta fino alla Liberazione.
Osvaldo Contestabile,
La Libera Repubblica di Pigna, ed.
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, 1985
Ai primi di settembre del 1944 sembrò per qualche tempo che la liberazione potesse essere vicina. Gli Alleati erano sbarcati in Provenza il 15 agosto, provocando un rapido crollo delle posizioni tedesche in tutta la Francia meridionale. Sembrava ora ragionevole attendersi un’offensiva generale degli americani attraverso i passi alpini, approfittando della stagione ancora clemente e dell’appoggio delle forti formazioni partigiane piemontesi e liguri, che certo non sarebbe mancato. Ma gli strateghi angloamericani avevano altri progetti: ritenendo prioritario l’attacco allo schieramento nemico tra i Vosgi e i Paesi Bassi, fermarono le loro truppe su una linea che lasciava il confine franco - italiano e l’intera valle del Roia saldamente in mani tedesche. Siffatta scelta, forse opportuna dal punto di vista militare, condannò tutto il Nord Italia ad un nuovo inverno di occupazione, ma, probabilmente, gli evitò le immani distruzioni causate dai combattimenti nel resto del Paese. Nel clima di fibrillazione di quei giorni, alimentato ad arte dalla trionfalistica propaganda di Radio Londra, i partigiani imperiesi della Prima Zona ligure, credendo fosse giunta l’”ora x”, abbozzarono una calata insurrezionale sui centri della costa che venne stroncata sul nascere da un vasto rastrellamento tedesco talmente tempista da risultare sospetto <1.
I savonesi, meno numerosi ed organizzati oltre che più distanti dal fronte, continuarono la loro attività di guerriglia con il consueto vigore, ma senza esporsi in arrischiate azioni su grande scala. Dopotutto, lo stesso Comando Generale delle Brigate Garibaldi avrebbe rammentato pochi giorni dopo che “L’ora x è già suonata” <2 e che pertanto l’obiettivo principale dei partigiani non doveva consistere solo nel prepararsi ad una futura insurrezione, bensì nell’attaccare giorno per giorno il nemico senza mai concedergli tregua <3. A Savona come altrove, questa direttiva giunse a conforto di una linea d’azione ormai perseguita da mesi.
[NOTE]
1 Per questa vicenda, tuttora piena di lati oscuri, vedi G. Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - La Stampa, 1985 (3 voll.), vol. II, pp. 10 - 22.
2 AA. VV., Le brigate Garibaldi nella Resistenza, Milano, INSMLI - Istituto Gramsci - Feltrinelli, 1979 (3 voll.), vol. II, p. 334.
3 Ibidem, vol. II, p. 334.
Stefano d’Adamo, “Savona Bandengebiet. La rivolta di una provincia ligure (’43-’45)”, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, Anno accademico 1999/2000
Finalmente anche il 6 di settembre [1944] finisce: il nemico riunisce i reparti rastrellatori, riforma le colonne, si concentra a fondo valle.
Il pugno di ferro si era stretto: che aveva preso?
Nulla, quasi nulla. Su più di un migliaio di partigiani, solo una decina erano caduti nella rete.
Alle ultime luci del tramonto, i tedeschi lasciano il bosco, le macerie fumanti di S. Bernardo di Conio, di Case Rosse, di Case dell’Erba, delle cascine e dei fienili distrutti, indicano che anche lì, come a Triora, a Molini, a Pornassio, a Villa Talla, erano passate le truppe di Hitler. Non note le perdite nemiche: la popolazione aveva visto scendere per la rotabile di Rezzo alcuni carri chiusi e sanguinanti.
Terminato il rastrellamento, il Comando Divisionale, su consiglio di
Curto [Nino
Siccardi], nuovamente dispone la sua dislocazione nel bosco di Rezzo, riuscendo a riorganizzare in brevissimo tempo tutta la Divisione, dai comandi ai distaccamenti, per prepararla alle previste battaglie autunnali.
In conformità alla critica storica, non si chiarì mai lo scopo degli annunci radio alleati della loro offensiva sulla costa ligure, poi mancata, con la conseguenza di determinare per alcuni giorni una situazione gravissima per le formazioni partigiane.
Il paese di Upega è posto a fondovalle.
Sotto il paese scorre il torrente Negrone, a monte un ripido pendio dirupato, di fronte è il Bosco Nero.
Il nemico che giunge dal bosco può piazzarsi senza essere visto, di fronte al paese, e di là battere col fuoco delle mitragliatrici, precludendo ogni via di scampo.
Il nemico era stato informato sul movimento partigiano: come prima sapeva che il Comando Partigiano era a Piaggia ed in quella direzione aveva puntato tutte le sue forze, presto venne a conoscenza che tale Comando si era trasferito a Upega, contro cui preparò un’azione condotta da un commando formato da circa duecento soldati SS e alpini austriaci.
La spia nel comando della Cascione aveva funzionato con efficacia.
L’attacco a Upega giunse dal Tanarello, da Limone o da Briga, e la sorpresa fu completa.
[17 ottobre 1944]
Il nemico si avvicina silenzioso, coperto dalla fitta boscaglia.
Al limite del paese, verso le Fascette, in una casa a destra, è il Comando divisionale.
A sinistra, in un altro locale, giacciono i feriti, tra cui
Cion [Silvio
Bonfante], che sonnecchia e a cui il
Curto ha preso il mitragliatore per andare a compiere un giro di ispezione.
I tedeschi riescono ad eliminare i posti di guardia partigiani e giungono alla periferia del paese senza essere segnalati.
Sono udite alcune raffiche, cadono alcuni partigiani di Porto Maurizio. Con il nemico a due passi e con gli spari che rimbombano vicinissimi, molti rimangono confusi e cercano di allontanarsi.
Chi conserva la calma è
Curto: impassibile come sempre, cerca di raggiungere chi si allontana, di ispirare loro fiducia, ma invano.
Fallito il tentativo di raggruppare i partigiani a scopo difensivo e strappare al nemico il tempo necessario per trasportare i feriti nella cappella del cimitero del paese o nel Bosco Nero, come era stato precedentemente convenuto,
Curto raggiunge al Comando il commissario
Giulio [Libero
Briganti], ed i due attuano il disperato tentativo di arrestare da soli l’avanzata del drappello tedesco. Sanno che è impossibile in due fermare la valanga, ma forse guadagneranno i pochi minuti necessari per mettere in salvo i feriti, per poi morire.
Giunti fuori dal paese scorgono, in alto a sinistra, i tedeschi che avanzano su due colonne distanziate.
Giulio e
Curto salgono rapidamente una mulattiera e, portatisi in cima algo, all’altezza dei tedeschi, si appostano dietro una casa. Da lì possono sparare a trecento metri con il mitragliatore contro il nemico quando sarà giunto a tiro.
Mentre
Curto prepara la propria arma semi inceppata,
Giulio scorge i tedeschi, si sposta fuori dal muro che lo ripara e li raffica.
Poi, rivolgendosi a
Curto, col viso pallido e lo sguardo stupito, mormora: “
sono ferito”.
Compie qualche passo indietro, a ridosso della casa, e consegna l’arma al compagno al quale si appoggia.
Arretrano entrambi qualche centinaio di metri, non visti dai tedeschi che tardano ad avanzare.
Le forze di
Giulio gradatamente cedono, non riesce più a camminare mentre Curto lo aiuta in tutti i modi ad andare avanti per raggiungere almeno una località sicura, tra le rocce, sopra il passo delle Fascette.
Dal basso giungono gli urli laceranti della mitraglia, l’eroico destino di
Cion e dei suoi compagni sta compiendosi.
Giulio si trascina ancora avanti: non desidera riposare in un grande cespuglio, ma alle rocce delle Fascette, da cui più in là non si può andare.
Un luogo nascosto ripara i due uomini: il ferito, disteso sul dorso e con il respiro ansante, ogni tanto a stento alza la testa per osservare i movimenti dei nemici sottostanti.
Preparate vicino a sé le armi automatiche per un’estrema difesa, e aperta la camicia piena di sangue,
Curto scruta la gravità della ferita del compagno: una pallottola, entrata a sinistra, è uscita alla destra del ventre, e anche i visceri sporgono fuori.
Capisce che per
Giulio è la fine, ma non gli dice niente e decide di attendere lì, a fianco, la sua morte.
Non gli rivolge domande su cosa dire ai parenti, affinché il morente non si accorga della sua fine.
Poi, il ferito entra in coma, respira affannosamente, chiede disperatamente acqua che
Curto non gli può dare: ha una gran sete, l’emorragia interna sussulto,
Giulio rimane esanime.
Coperto pietosamente il corpo con la giacca, raccolte le armi e incamminatosi oltre il passo delle Fascette, alle otto di sera Curto giunge a Carnino, ove reca la dolorosa notizia.
Anche
Cion (che è nipote di Curto), ai primi spari, viene portato fuori dal ricovero, adagiato sulla barella dai partigiani e dai congiunti che si trovavano con lui: per non cadere vivo in mano ai tedeschi si uccide con un colpo di pistola, sul sentiero che porta al cimitero.
La tragedia si conclude, il comandante della
Volante muore da partigiano.
I tedeschi domandano chi era il ribelle suicidatosi, e viene loro riferito che si trattava di
Cion.
Non avevano potuto averlo vivo, ma la radio tedesca in Italia diede la notizia della morte di
Cion come un successo delle sue armi.
Questo fu certamente l’omaggio più grande alla sua memoria ed il riconoscimento di quanto egli valesse e di quanto avesse perduto la Resistenza con la sua morte.
I tedeschi, occupato il paese, bruciano armi, documenti, zaini e tutto quello che di partigiano viene trovato.
Rinchiudono gli uomini del paese nella canonica.
Fanno scavare una fossa comune dagli abitanti locali e vi gettano alla rinfusa i cadaveri dei caduti.
Battono il bosco, uccidendo altri partigiani.
La tragedia di Upega è costata alla Resistenza quasi una ventina di caduti.
Nei boschi, dispersi, sono nuclei di partigiani, sono intere bande.
C’è
Simon [Carlo
Farini] su una barella.
“
Ci troviamo a Piaggia di Briga Marittima”, scrive il cappellano partigiano Don Nino Martini nella prima metà del mese di ottobre, “
Simon ha una temperatura variabile tra i 39 e i 40 gradi di febbre. Intanto le notizie che giungono sono sconcertanti. Gli Alleati, fissandosi sulla frontiera italo-francese secondo i piani prestabiliti, danno libertà e agibilità alla ferocia di qualche migliaio di nazifascisti e delle SS tedesche contro i partigiani. Noi, riuscendo a uscire fuori dal rastrellamento, troviamo rifugio e salvezza in Valle Scura, dove Simon riuscirà a guarire”.
Francesco Biga, U Curtu - Vita e battaglie del partigiano Mario Baldo Nino Siccardi, Comandante della I^ Zona Operativa Liguria, Dominici editore, Imperia, 2001
Francesco Agnese. Nato a Diano Marina il 29 luglio 1923. Il 25 marzo
1944 di ritorno da Genova viene arrestato alla stazione di Diano Marina
da un reparto di fascisti della famigerata compagnia O.P. del capitano
Ferraris; prima dell’arresto riesce a consegnare al fratello Mario un
rotolo di volantini “Stella Rossa”. Trascinato al comando fascista di
Diano Marina, quindi alla caserma Muti di Porto Maurizio, infine intorno
al 4 aprile è rinchiuso nelle carceri di Oneglia subendo numerosi
interrogatori e bastonature. Avendo lui ed altri prigionieri la
possibilità di evadere, grazie all’azione di un tenente fascista (in
contatto con i partigiani), non approfitta dell’occasione, per timore di
rappresaglie nei confronti dei parenti. Uscirà dal carcere a fine
maggio. Nel luglio 1944 prende contatto con Giuseppe Saguato “Bill” e
concorre a formare uno dei primi distaccamenti garibaldini nella vallata
di Diano Marina che, raggiunto il numero di ottanta unità, andrà a
costituire la “Volantina” di “Mancen”. “Socrate” è molto intraprendente:
con Saguato disarma due carabinieri e partecipa agli assalti alle
caserme per il recupero di armi; con il suo distaccamento partecipa alle
battaglie di Cesio (mettendo in fuga i tedeschi); di Rezzo, combattendo
per sei ore e conquistando Monte Alto. E’ in missione a Diano Marina,
liberando la città dalla presenza del brigatista nero Enrico Papone.
Rientrato al comando è promosso Commissario di battaglione e passa con
Germano Tronville “Germano” presso Upega, in Val Tanaro. Il 17 ottobre è
tra coloro che tentano di sottrarre “Cion”, (immobilizzato perché
ferito a Vessalico l’8 ottobre) al fuoco tedesco, trasportandolo in
barella. E’ colpito da una raffica, cade, e muore dissanguato nel bosco.
A
Francesco Agnese è intitolato un Distaccamento della Brigata “Silvano
Belgrano” - Divisione d’assalto Garibaldi “Silvio Bonfante”.
Redazione, Arrivano i
Partigiani - inserto - "2. Le formazioni di montagna della I^ e della VI^
Zona Operativa Ligure che operavano nella provincia di Savona", I RESISTENTI, ANPI Savona, 2011
A Upega durante la ritirata si erano radunate gran parte delle
forze partigiane contro cui era iniziato il rastrellamento di oltre 5000
militari tedeschi. I patrioti avevano portato lì anche i feriti.
Pensavano di essere al sicuro avendo il Mongioie alle spalle. Era il 17
ottobre del 1944. I partigiani che erano arrivati a Upega dopo giorni di
cammino, col freddo e la fame, erano stremati. Non sapevano che la
spia, che avevano tra loro aveva già segnalato la loro posizione, ai
nazisti i quali poterono così sorprenderli, uccidendo le sentinelle che
non poterono dare l’allarme. Due comandanti partigiani cercarono di
contrastare il più possibile l’avanzata, soprattutto per permettere ai
feriti di mettersi in salvo. Caddero in questo impari compito il
comandante Silvio Cion Bonfante ed il comandante Libero Giulio Briganti. Cadde anche il medico De Marchi. I garibaldini nel complesso subirono ingenti perdite. I tedeschi devastarono le case e rastrellarono la zona. Alcuni dei patrioti allo sbando furono catturati da militari tedeschi
tra il 17 ed il 18 ottobre sul territorio di Briga Marittima e furono
trascinati nella vicina Saorge. Torturati per più giorni, vennero
fucilati in zona Pont d'Ambo, dominante il letto del fiume Roia, al
limite con il comune di Fontan. Saorge era sede del tribunale militare
della 34^ Divisione di fanteria tedesca, che occupava il territorio da
Imperia al Col di Tenda. Subito dopo la tragica farsa del tribunale,
avvenuta il 24 ottobre 1944, lo stesso giorno i garibaldini, legati
l'uno all'altro, furono trascinati attraverso il villaggio davanti agli
abitanti atterriti fino al luogo dell'esecuzione, dove furono costretti a
scavare le loro fosse. I partigiani fucilati a Saorge il 24 ottobre 1944 furono Lorenzo Alberti
“Renzo”, catturato sul territorio di La Brigue il 18 ottobre, Michele
Bentivoglio “Miché”, Francesco Caselli “Pancho” o “Guido”, catturato sul
territorio di La Brigue il 17 ottobre, Giovanni Giribaldi “Gianni”,
Domenico Moriani “Pastissu”, comandante di Squadra, Carlo Pagliari
“Parma”, catturato sul territorio di La Brigue il 17 ottobre [...] Igor Pizzirusso, Saorge..., Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana
 |
| Pagina 15 del Notiziario GNR cit. infra - Fonte: Fondazione Luigi Micheletti |
Da informazioni giunte risulta che nel corso delle recenti azioni di rastrellamento, eseguite dalla G.N.R. e da militari tedeschi, sono rimasti uccisi certi Francesco Castagno, padre del commissario della banda "stella rossa"; Silvio Bonfante, detto "Cion" vice comandante della 2^ divisione d'assalto, "Felice Cascione"; Simone [
n.d.r.: probabile riferimento - storpiato - a "Simon", nome di copertura di Carlo Farini, a quella data responsabile sia della I^ che della II^ Zona Liguria, poi ispettore della I^, in seguito ancora
assurto a responsabilità regionali in seno alla Resistenza], noto capo banda della stessa divisione e certo Lupi, capo banda nella zona di Savona.
E' rimasto gravemente ferito certo Vittorio Acquarone, comandante della divisione medesima, nonché la madre del commissario Castagna.
Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del giorno 8 novembre 1944, p. 15,
Fondazione Luigi Micheletti